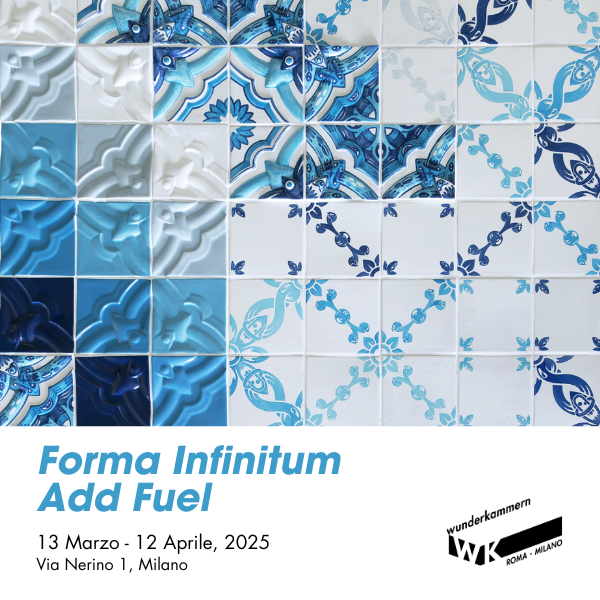Invincibile, ribelle, mai domata da nessuno: “Carmen” compie 150 anni e sembra non dimostrarli. Era il 3 marzo 1875 e all’Opéra-Comique di Parigi andava in scena, per la prima volta, la “creatura” musicata da Georges Bizet. La prima rappresentazione fu un mezzo fiasco. Chi era questa “Carmen”, sensuale gitana che voleva decidere della sua vita, cambiava amanti a seconda del desiderio del momento e alla fine soccombeva solo di fronte alla brutalità maschile?
Purtroppo per Bizet, l’enorme successo dell’opera arriverà quando ormai lui sarà morto già da diversi mesi. Inizialmente, infatti, la critica giudicò la protagonista femminile, e con lei l’opera nel suo complesso, con criteri influenzati dalla morale dell’epoca. Un critico arrivò a definire Carmen “personaggio incarnazione del vizio”. Del resto, la bella gitana, che ancora oggi, 150 anni dopo, ci appare ossessivamente legata al suo essere fiera, indipendente, fino alle estreme conseguenze, allora doveva apparire ben lontana dalle eroine operistiche tradizionali, solitamente nobildonne, regine, sacre sacerdotesse.
Carmen era una gipsy che lavorava in una fabbrica di sigarette a Siviglia e utilizzava il suo sex appeal per sopravvivere e farsi largo in una società violenta e maschile, riuscendo a piegare gli uomini al suo volere. La prima rappresentazione italiana avvenne a Napoli, al Teatro Bellini, nel 1879: in quel periodo la città, disseminata di conservatori e nel pieno di un certo fermento culturale, rappresentava forse la sede ideale per tributare a quell’opera e a quel personaggio così “nuovo” e particolare una fetta del successo che faticosamente iniziava a consolidarsi anche in altre parti d’Europa.

“Carmen” era una vera sfida per la morale dell’epoca ma, se ancora oggi sa parlarci, è anche grazie alla capacità di Bizet di ridisegnare le regole operistiche e drammaturgiche del tempo. Tra queste anche l’utilizzo della lingua francese. «Il ricorso a questa lingua – spiega ad Artuu Magazine Michelangelo Iossa, professore di Musicologia all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli – , che conteneva comunque elementi di ispanità, fu un primo elemento di rottura. Fino ad allora a dominare erano stati l’italiano e, con Wagner, il tedesco. Anche l’ambientazione, popolaresca, spagnola, lontana dalla tradizione seguita fino a quel momento, fece gridare allo scandalo».
“Carmen” ha infatti segnato uno spartiacque non solo per la scrittura della protagonista, ma anche per il richiamo a elementi culturali e musicali spagnoli e rom. Al tempo del debutto di “Carmen”, la Spagna, agli occhi di un francese, appariva come una realtà “esotica”. Nonostante fosse geograficamente vicina alla Francia, separata solo dai Pirenei, che tuttavia rappresentavano una sorta di barriera culturale. La stessa “Habanera”, l’aria più iconica dell’opera e cavallo di battaglia di tante divine della lirica, a cominciare da Maria Callas, può essere letta secondo questo doppio schema.

È un canto di liberazione e affermazione di indipendenza femminile, che definisce perfettamente la filosofia di vita della protagonista, ma è anche musicalmente una grande innovazione. L’aria è infatti costruita su un ritmo di habanera, una danza cubana che Bizet ha adattato da una melodia di Sebastián Iradier. Un ritmo sincopato e sensuale, insolito per l’opera francese dell’epoca, che conferisce alla musica un fascino folkloristico, popolare e accattivante. Bizet, che non aveva mai visitato la Spagna ma ne studiò gli elementi musicali, intendeva solo “richiamare” quel mondo senza scimmiottarlo, nel pieno spirito musicale dei tempi.
E oggi, dopo 150 anni, Carmen continua a influenzare la rappresentazione dei personaggi femminili, anche al di fuori del recinto operistico e teatrale. La gitana di Bizet ha ispirato non solo la musica e l’opera, ma anche il cinema, con adattamenti e reinterpretazioni cinematografiche diventate più o meno famose. Persino Beyoncé si è messa alla prova in una versione hip-hop dell’opera. «Carmen – conclude Iossa – rappresenta l’autodeterminazione femminile, con l’elemento della libertà sessuale volta a smascherare le debolezze e le ambiguità maschili. Il personaggio è ancora moderno perché è un archetipo. Per questo il suo impatto è gigantesco: è come un eroe mitologico, può essere reinterpretato tante volte quante sono le sensibilità del tempo».