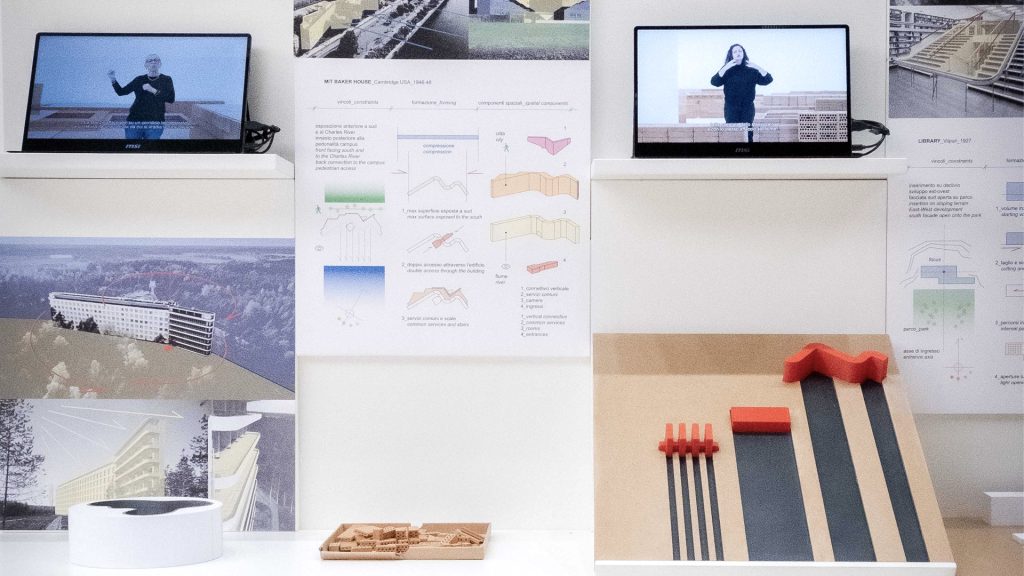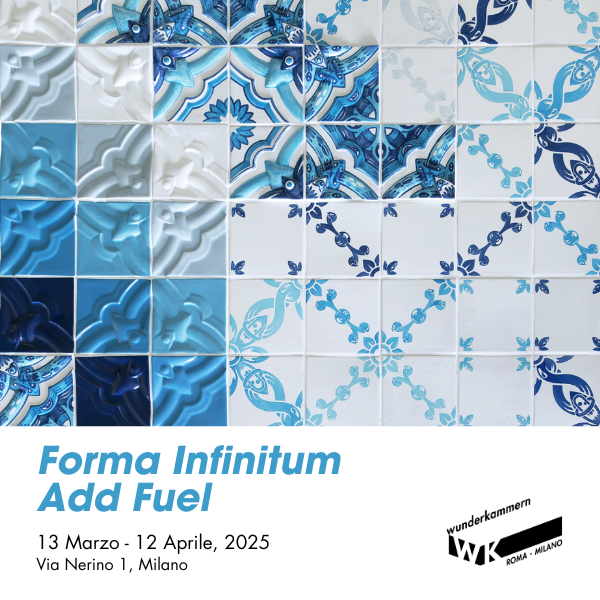Per easy-to-read si intende un linguaggio semplificato, pensato per essere più comprensibile e di facile accesso per chi ha bisogno e voglia di capire il messaggio che il testo veicola in modo più immediato. Le informazioni scelte sono essenziali e reader-based, presentate attraverso una sintassi lineare, un lessico semplificato, una forma grafica particolare e numerose immagini a corredo.
Sebbene l’Europa ne raccomandi l’impiego e alcuni paesi come la Germania e la Svezia abbiano provveduto a rendere disponibili i testi anche digitali, inerenti le varie istituzioni, con pagine facilitate, l’Italia inizia a muoversi da neofita tra le raccomandazioni e gli esempi virtuosi, avvicinandosi all’argomento con molto interesse, soprattutto per ciò che riguarda la programmazione didattica dei musei.
Finora nel nostro paese l’Anffas – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali, ha redatto, sulla base delle indicazioni proposte dall’UE, testi semplificati per vari documenti ufficiali, oltre che delle istruzioni utili alla vita quotidiana o anche brevi guide in occasione di eventi, mostre e percorsi museali.
Diversi sono i musei che hanno cercato di applicare queste stesse linee guida, adattandole alle specifiche esigenze di ciascuno, in assenza sia di un coordinamento generale dato dal MIC sulla questione, sia di un confronto di pratiche tra i vari musei, sia infine di studi sistematici sui visitatori che permettano di migliorare e aggiornare le linee guida stesse.
Tra i vari progetti portati avanti, Trieste sembra essere la città all’avanguardia dal punto di vista museale: i suoi Musei di Storia Naturale e della Letteratura, avvalendosi dei contributi dei più importanti professionisti internazionali del settore, hanno previsto spiegazioni in linguaggio facilitato.
La ricerca nel settore è ancora per lo più a livello teorico e necessita di sviluppi pratici, in particolare per ciò che riguarda i Reception Studies. Un progetto in questa direzione è stato condotto anche nella Pinacoteca di Brera a Milano dove, nell’ambito della sua ricerca dottorale presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, la dottoressa Valeria Farinacci ha portato avanti una proposta di traduzione bilingue dalle lingue standard a quelle semplificate e ha ideato testi per i pannelli in ‘Easy Italian’ – ‘Easy English’, studiandone l’impatto in termini di interazione sul pubblico (Farinacci, V. 2024, The impact of retranslation on museum interaction. Results from the Brera Art Gallery. Unpublished doctoral dissertation. University of Modena and Reggio Emilia).
Questo perché la lettura è una competenza fondamentale, basata su meccanismi complessi e delicati, alla base di molte delle interazioni con il mondo e che perciò necessita di un approccio non settoriale ma multidisciplinare che la colleghi ad esempio con la pedagogia e la museologia, per contribuire attraverso una visione integrata e complessa ad allargare l’orizzonte dell’accessibilità stessa e della traduzione.
Frasi minime o brevi, scelte lessicali tratte dal linguaggio quotidiano, impostazione grafica che fa uso di una formattazione utile ad individuare immediatamente le parole-chiave non sono una diminutio ma una ulteriore possibilità di partecipazione nata per persone con disabilità intellettive e con capacità di concentrazione limitata, ma adatta anche ad altri fruitori come bambini, anziani, stranieri, persone con un basso livello di scolarizzazione o competenze linguistiche limitate.
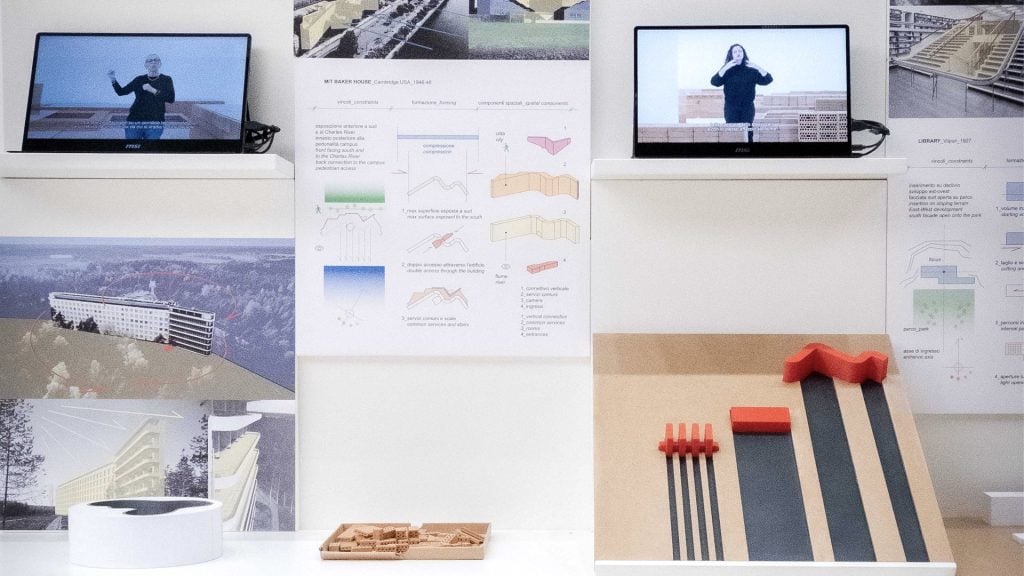
Senza contare che un testo facile, scritto chiaramente, può essere adatto anche a chi ha competenze più avanzate, permettendogli di individuare subito il messaggio veicolato come principale, di interrogarsi criticamente sul meccanismo di semplificazione adottato, sugli obiettivi del testo, sulle scelte lessicali del traduttore e sui diversi modi di apprendere che caratterizzano il nostro essere nel mondo.
E se a preoccupare è il possibile rischio di un ulteriore impoverimento culturale, l’antidoto sarà considerare queste traduzioni uno strumento possibile tra tanti di mediazione, ma non l’unico.
Al pari ad esempio delle guide di comunicazione aumentativa alternativa (CAA) che sfruttano anche una serie di simboli visuali stereotipati, anche i testi in easy to read dovrebbero essere proposte in aggiunta ad altri strumenti di comprensione delle opere, degli allestimenti e degli spazi, intendendole come possibilità di incrementare la naturale comunicatività delle persone, migliorandone la fruizione e la condivisione, permettendo alla complessità dei diversi approcci di generare nuovi inesplorati orizzonti di partecipazione.