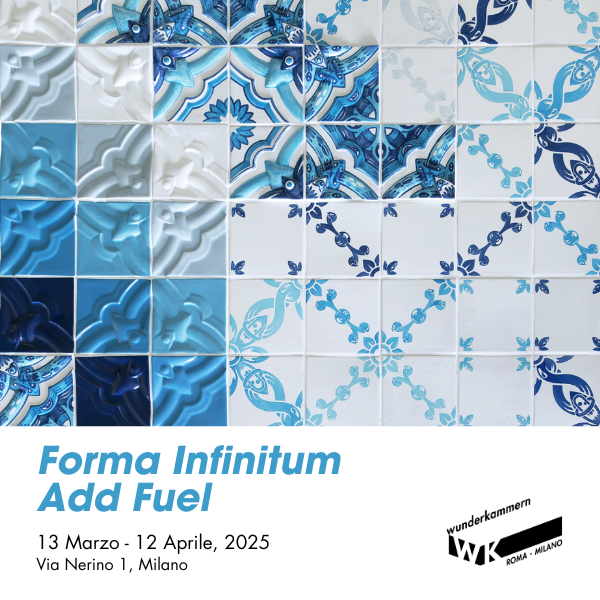Le polemiche divampano da qualche settimana. Chi decide cosa sia lecito esporre negli spazi pubblici? A lanciare la polemica era stato Artribune, con un articolo del suo direttore, Massimiliano Tonelli, che aveva stigmatizzato un intervento di arte pubblica a Firenze, definito “un minestrone di scadente arte pubblica contemporanea ai piedi del Duomo di Firenze”. Pomo della discordia, un’installazione di Marco Lodola, L’attesa, che raffigura una panchina rossa lunga 4 metri su cui siedono 3 donne di diverse generazioni, a cui erano stati affiancati due giganti che guardano il cielo, opera di Emanuele Giannelli. Tutte opere allineate di fronte a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione. Nel suo articolo, Tonelli auspicava la costituzione di “comitati” formati da critici riconosciuti per decidere cosa può essere degno di essere esposto nelle piazze italiane, lamentando che, per affiancare opere contemporanee a capolavori del Rinascimento realizzati da maestri indiscussi dell’arte e dell’architettura del calibro di Arnolfo di Cambio, Filippo Brunelleschi, Michelangelo e Donatello, il livello “deve necessariamente essere paragonabile ai giganti di cui sopra” (come se esistesse qualche artista contemporaneo solo vagamente paragonabile a talenti del genere…). Se per Artribune, insomma, Giannelli “non ha i titoli per stare nel luogo straordinario dove è stato messo”, anche per Lodola “qualche dubbio sul fatto che meriti di esporre di fronte al Duomo di Firenze c’è eccome”.

Anche noi, una decina di giorni fa, siamo intervenuti sull’argomento, con un articolo intitolato “Arte pubblica, quant’è bello provocare da Firenze in su. Ma che cos’è un monumento e perché realizzarlo oggi?”, nel quale abbiamo ricordato come molti interventi di arte pubblica in Italia, pur realizzati con tanto di critici e di comitati scientifici, siano assai discutibili da ogni punto di vista (formale, concettuale) e abbiano standard qualitativi quantomeno modesti, e come invece altri interventi del passato recente, magari illegali o estemporanei, abbiano invece suscitato ben più interesse toccando corde sensibili del contemporaneo (due fra tutte, l’intervento “minimal” di Ivan il Poeta sul celebre “dito di Cattelan” in piazza Affari a Milano per sensibilizzare sul tema della violenza di genere, e il recente monumento “ricoperto di stoffe” del duo Urban Solid a Busto Arsizio).
Nel frattempo, però, assieme alle polemiche, non si sono fatte attendere frecciate, meme, sfottò, e persino qualche caduta di stile, come quella che il comico Alessandro Arcodia ha rivolto alla scultura di Lodola nella trasmissione Splendida Cornice di Geppi Cucciari su Rai 3, dove ha liquidato l’installazione con le tre donne con un “Grazia, Graziella, e grazie alle amicizie in Regione Toscana”. Ma davvero oggi basta questo per delegittimare un’opera? È sufficiente un affastellamento visivo – frutto più che altro di una cattiva gestione degli spazi – per sollevare un’accusa di “amichettismo” (per dirla con lo scrittore Fulvio Abbate, che ha coniato il temine)? E, soprattutto, chi decide cosa ha diritto di stare nello spazio pubblico?
A questo punto non potevamo che intervistare lui, Marco Lodola, per sapere cosa volesse rispondere a quanti hanno messo in dubbio la qualità del lavoro e l’autorevolezza del suo curriculum, e per capire da dove nascesse l’installazione, da chi fosse stata commissionata e perché. In un’intervista a caldo, diretta, senza sconti, Lodola chiarisce il contesto dell’opera, difende la funzione sociale del progetto, e rivendica – con lucidità – il diritto di essere giudicato sul lavoro, e non sulle insinuazioni di presunte amicizie per esporre le sue opere.

Marco, partiamo dall’inizio. Come nasce la scultura L’attesa?
Tutto è cominciato con un incarico ricevuto da Pedale Rosso, un’associazione che organizza manifestazioni ciclistiche con un messaggio forte: contrastare la violenza sulle donne. All’interno dell’associazione ci sono figure come Marianella Bargilli, l’attrice, e Paolo Bettini, ex campione olimpico. In vista di una tappa a Firenze, nel novembre scroso, mi hanno chiesto di realizzare un’opera per accompagnare simbolicamente il loro passaggio. Così mi hanno coinvolto, ne abbamo ovviamente parlato con Cristina Manetti, Capo di Gabinetto della Regione Toscana, ma anche ideatrice del progetto Toscana delle donne, della Regione Toscana. E dico sì, subito, perché il progetto mi toccava anche a livello personale.

Dunque un progetto sociale, con il corollario di altre iniziative culturali e artistiche, con nomi importanti impegnati a dare il proprio contributo su temi come la parità di genere, la lotta all’odio e alle discriminazioni. Nessun amichettismo, allora, come ha insinuato una trasmissione satirica su Rai 3?
Macché amichettismo o amicizie in Regione. Io in Toscana ho già lavorato molto, a chiamata e non certo per amicizia. A Firenze ho studiato, ho fatto l’Accademia di Belle Arti, ho esposto a Palazzo Medici Riccardi, ho un’opera permanente nel Corridoio Vasariano, sono presente nelle collezioni di Pananti, Tornabuoni, alla Fondazione Bocelli. Qualcuno evidentemente ha ritenuto che il mio lavoro fosse valido. E non ho mai pagato o pregato per essere esposto, ogni sono stato chiamato e ho avuto gli incarichi, per il mio lavoro e il mio curriculum…
Già, il tuo curriculicum, su cui Artribune ha avuto da ridire… Eppure è di tutto rispetto, fin dagli anni Ottanta sei stato tra i protagonisti del Nuovo Futurismo, hai esposto in Biennale, in manifestazioni di prestigio e in molti musei e spazi pubblici in Italia e all’estero. E hai anche collaborato con marchi di moda internazionali, come Dior…
Esatto, con Dior ho collaborato a un progetto straordinario, che ha toccato le vetrine e l’allestimento di oltre 400 negozi nel mondo. Ma gho collaborato anche con Swatch, con il Teatro alla Scala, col Palio di Siena, con grandi eventi sportivi e culturali. Ho lavorato in Europa, in America, in Medio Oriente. Durante i Mondiali in Qatar, per esempio, ho realizzato sette chilometri di installazioni luminose dedicate al tema dell’incontro tra popoli. Sono sempre stato un artista “popolare”, nel senso più profondo del termine: lavoro per la gente, nello spazio pubblico, creando opere che parlano a tutti, non solo ai critici o agli addetti ai lavori.

Torniamo alla scultura: cosa voleva significare dunque la “panchina rossa” oggi finita nel mirino di critici e battutari?
La panchina rossa è un simbolo chiaro, riconosciuto ovunque, nato per ricordare le vittime di femminicidio e per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Non è un vezzo decorativo, non è un elemento accessorio: è il cuore dell’installazione. Io ho voluto inserirla al centro di una scena che racconta tre generazioni di donne – una dell’Ottocento, una contemporanea e una bambina – sedute insieme, in attesa di un cambiamento. È un passaggio temporale, una specie di arco simbolico tra passato, presente e futuro. Ed è un’immagine di speranza, di attesa attiva, che vuole coinvolgere chi guarda, anche chi passa per caso. È un invito a riflettere, senza retorica ma con forza. E invece è stata banalizzata, persino derisa. Questo fa male, perché dietro quella scultura c’è una motivazione profonda, un tema importante, e anche un lavoro fatto in collaborazione con chi da anni si spende davvero su questi temi.
Quella collocazione così ravvicinata con l’installazione di Giannelli, in effetti ha creato un affastellamento visivo. Ma tu sei stato il primo a sollevare il problema, giusto?
Certo, subito. Ho visto una foto di queste sculture che sono state installate proprio accanto alle mie, e ho chiamato Cristina Manetti: “Così non va, è sbagliato”, le ho detto. Non per polemica, ma per senso estetico. C’erano due opere molto diverse, vicinissime, che finivano per disturbarsi a vicenda. Non c’era alcuna intenzione di creare una “gara di statue”, ho solo chiesto che si rivedesse la disposizione, ma a quanto pare la cosa non dipendeva da me. E poi è dovampata la polemica…
Certo, la polemica, ma anche i meme, gli sfottò…
Sì, e devo dire che quella battuta – “Grazia, Graziella e grazie al… le amicizie in Regione Toscana” – in una trasmissione come Splendida Cornice che si propone come intelligente, critica ma anche sensibile e attenta ai diritti, è stata una caduta di stile sconcertante. Anche perché ha offeso non solo me, ma tutto il progetto e soprattutto l’associazione Pedale Rosso, fatta di persone che lavorano seriamente, spesso gratuitamente, su temi delicati. Lì ho davvero pensato che si fosse superato un limite. Le polemiche vanno sempre bene, gli insulti e le accuse false no.

In molti, però, invocano regole più rigide per l’arte pubblica: comitati scientifici, bandi, selezioni… Tu cosa ne pensi?
Che è una follia pensare di centralizzare tutto. L’arte pubblica nasce in tanti modi: a volte nasce da un bando, altre volte da un incarico diretto, un omaggio, un progetto sociale. Non esiste un solo modello. E poi, scusa: chi avrebbe deciso la collocazione delle tante opere che si vedono in giro per le piazze italiane? Quale sarebbe il comitato che ha scelto quegli artisti e non altri? Nell’arte pubblica ci sono o ci possono essere tanti attori diversi, e, se non vogliamo essere ipocriti, dobbiamo dire che quasi sempre dietro un’opera c’è un mix di scelte politiche, di sponsor, di contesto artistico, che non è mai monolitico ma piuttosto fluido. Pensare che tutto debba passare per una “giuria” è ingenuo, o ipocrita. Quanto al curriculum, se gli artisti dovessero essere sempre al livello di Michelangelo o di Brunelleschi per esporre negli spazi pubblici, beh, confesso che ho qualche difficoltà nello scovare invece, tra i critici italiani, i degni eredi del Vasari…
Alla fine insomma è il tempo che seleziona e premia le opere, non i comitati o i bandi…
Esatto. Il giudizio sull’arte lo dà il tempo. Non un articolo, un critico, un giornalista, un comitato, e men che meno una battuta in TV. Van Gogh è stato ignorato per tutta la vita. Botticelli è stato riscoperto dopo due secoli. Nel caso dell’arte pubblica, ancora più che nei casi delle opere esposte nelle gallerie, è il pubblico ad avere un ruolo decisivo. La gente che passa, che guarda, che si emoziona o si riconosce in un’opera: quello per me è un vero termometro. Io lavoro da quarant’anni per le persone, non per le élite. In questo senso, mi sento un artista “popolare” nel senso più autentico del termine. Il pubblico ti guarda, ti ascolta, si emoziona o ti ignora. Alla fine, non gli interessa chi ti ha chiamato, chi ha curato o sponsorizzato l’opera… Se l’opera tocca, se piace, funziona. Se non tocca, muore. Tutto il resto è rumore di fondo.