Storica dell’arte, progettista culturale, docente di Storia dell’Arte all’Accademia di Belle Arti di Catania, è Direttrice del Museo Civico di Castelbuono (che ha sede nel Castello dei Ventimiglia a Castelbuono, piccolo borgo medievale che sorge nel Parco delle Madonie in provincia di Palermo, ndr), dove da dieci anni guida un progetto museale che sperimenta pratiche di comunità e una programmazione che valorizza il patrimonio culturale, ispirandosi ad un approccio basato su sostenibilità, innovazione tecnologica, linguaggi contemporanei. Fino al 2023 ha diretto il mudaC–museo delle arti di Carrara, Città Creativa Unesco, di cui ha ideato e realizzato il nuovo assetto museografico e il riallestimento della collezione permanente, secondo strategie di fruizione accessibile e ricostruzione delle relazioni tra museo e comunità. Negli ultimi cinque anni, risultato di una progettazione mirata alla crescita dell’Istituzione in rapporto al territorio, il Museo Civico di Castelbuono ha ottenuto finanziamenti pubblici a sostegno di progetti culturali per circa mezzo milione di euro. Recentemente è stata chiamata tra gli esperti nazionali ai tavoli di lavoro del RavelloLab 2024, per reimmaginare le relazioni tra intelligenza artificiale e patrimonio culturale, e ai tavoli del NextGen Cultural Heritage, curato da Università Cà Foscari di Venezia e Fondazione CHANGES, per ripensare le strategie nazionali sui beni culturali, sul tema del “Citizen Science: partecipazione dei cittadini alla ricerca e alla governance dei beni culturali”. È attualmente Direttrice Artistica del progetto “Rosalia400” per la Fondazione Sicilia per il progetto PNRR-CHANGES Spoke 9–Cultural Resources For Sustainable Tourism.
Ecco cosa ci ha raccontato.

Come si può rendere più accessibile oggi il patrimonio culturale?
Se gli obiettivi sono quelli già espressi dalla “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società” – che l’Italia ha sottoscritto nel 2013 e ratificato solo nel 2020 – cura e partecipazione rappresentano strumenti di coinvolgimento alternativi e più diretti, affinché il patrimonio sia egualmente accessibile a tutti. Nell’immaginario collettivo infatti le attività culturali, tradizionalmente intese, sono spesso rivolte a pochi ed esperti, o ancora peggio, si considerano gli spazi culturali come beni di consumo turistico di tipo “estrattivo”, dove la visita è percepita come una esperienza frustrante e noiosa. Dalla riscrittura delle didascalie delle opere, ai percorsi “mediati” da sistemi e tecnologie di ingaggio cognitivo, sono ormai infinite le possibilità per rendere il “museo disponibile” ad accompagnare i visitatori nella scoperta e nella condivisione del patrimonio: una relazione fondata su obiettivi comuni tra il valore del patrimonio e il suo impatto in termini di crescita sociale.
È già in atto questo cambiamento?
Alcuni musei e istituzioni culturali sensibili ai temi del cambiamento (climatico, politico, sociale, economico) hanno da tempo maturato questa consapevolezza. Tuttavia, si tratta anche di liberarsi di una certa retorica della “bellezza”, una nozione svuotata di senso, obsoleta. Sarebbe opportuno, piuttosto, parlare di responsabilità sulla salvaguardia della bellezza, e riconoscere i musei come spazi di formazione, dove immaginare e condividere criteri e saperi, dove adottare nuovi formati culturali, basati sul principio della co-progettazione, della partecipazione dal basso, del coinvolgimento delle persone e dei pubblici, a partire dal contesto civico in primis. Manuel Borja-Villel, già Direttore del Museo Reina Sofìa, del MACBA e teorico militante della decolonizzazione nei musei, a Barcellona sta attualmente conducendo “Museu Habitat“, un progetto per rifondare il sistema museale catalano attraverso una ricerca radicale, per passare dal museo enciclopedico settecentesco alla creazione di una istituzione democratica e inclusiva.
E in Italia?
In anni recenti, alcune istituzioni italiane, tra cui il Museo Egizio e il MAO-Museo d’Arte Orientale di Torino, il Museo delle Civiltà di Roma, i Musei Civici di Reggio Emilia, hanno adottato nuovi criteri museali, dalla riorganizzazione delle collezioni, alla classificazione disciplinare delle arti, all’attivazione di nuovi strumenti di partecipazione. Inoltre le riflessioni teoriche sollecitate da ICOM-International Council of Museum nel dibattito internazionale, sono accompagnate dall’attuazione degli interventi previsti nelle misure del Ministero della Cultura con i fondi PNRR per l’industria culturale e creativa 4.0, in linea con il Quadro d’azione europeo sul Patrimonio Culturale del 2019.

Da dove ha origine questa riflessione sul rapporto tra la comunità e il suo patrimonio?
Le istituzioni culturali oggi non rappresentano soltanto il luogo della conservazione e della presentazione gerarchica dell’oggetto culturale, ma sono luoghi del “vissuto”, dove sperimentare nuove forme di relazione e pratiche di “Citizen Science”, un campo disciplinare che riguarda la collaborazione dei cittadini alla conoscenza del patrimonio culturale. Si tratta di una pratica diffusa già dalla fine degli anni Novanta, anche grazie alle reti sociali e all’evoluzione di competenze per la raccolta e la condivisione di dati. La “tutela sociale del patrimonio” è riconosciuta come la capacità dei cittadini di sapersi prendere cura non solo dei beni, ma di quell’insieme di valori collettivi immateriali (storici, etici e culturali) su cui si fonda il patto di responsabilità tra individuo e società. L’utilità pubblica da essa generata, anche nei termini di crescita collettiva, investe le istituzioni culturali pubbliche e private, di un ruolo-guida. Come già espresso nella Conferenza di Praga di ICOM, nel 2022, il cambiamento affrontato negli ultimi anni, ha riconosciuto ai musei l’impegno a condividere pratiche e policy a sostegno dello sviluppo sostenibile, a partire dalle strategie applicabili a livello locale. Ogni piccolo, medio o grande museo può agire per promuovere le proprie attività in considerazione di questa comune prospettiva.
In che modo le istituzioni culturali possono mettere in atto queste nuove dinamiche proattive?
Bisogna rafforzare il dialogo tra istituzioni culturali, scuola, studenti e corpo docente, associazionismo civico, artisti e creativi, comunità locale, diversificando la natura dei pubblici e le modalità di engagement, con progetti anche di “piccola scala”, ma continuativi. È altrettanto indispensabile riconoscere alle professioni museali un ruolo-guida: sono spesso i contesti amministrativi ad essere carenti di figure specializzate nella gestione delle istituzioni culturali, con l’ovvio effetto di depotenziare la governance e le condizioni di promozione del patrimonio. Inoltre anche le architetture dei musei dovranno immaginare spazi dedicati alla partecipazione e condivisione, “piazze” per la co-progettazione e sempre più pensati “a misura di persona”. In questa prospettiva, dunque, si chiede provocatoriamente lo storico americano Steven Conn: “I musei hanno ancora bisogno di oggetti?”. Bisognerebbe forse riformulare le dinamiche museali in considerazione delle priorità e delle urgenze ambientali che il tempo storico ci impone, piuttosto che continuare a produrre ‘cose’? Ripensare quindi la produzione culturale in funzione ecologica, affiancando alle consuete attività di programmazione museale, azioni artistiche volte a sollecitare una responsabilità individuale e collettiva sull’ambiente, sul paesaggio, in quanto parti del patrimonio?

Cosa bisogna fare per trasformare un museo in hub culturale, ovvero in un luogo di esperienza e non solo di esposizione?
L’innovazione non è strettamente legata all’uso della tecnologia, piuttosto è la trasformazione del contesto sociale – l’empowerment in esso generato – che determina un effetto più significativo sul lungo periodo. Costruire la relazione tra comunità e istituzione sollecita i processi di appartenenza, aiuta a riconoscere quel patrimonio come imprescindibile e intrinseco alla vita civica. Il percorso di accreditamento di un museo come spazio di esperienza e partecipazione avviene solo se avviene con modalità riconoscibili e con continuità, istituendosi come asset strategico. Spesso l’occasionalità delle iniziative museali è causa dell’impossibilità di ritrovare una specifica offerta culturale nel tempo e la mancanza di occasioni di partecipazione. Dalla comunicazione on line e off line, dall’uso di infografiche accessibili e comprensibili, da programmi pubblici che prevedono la partecipazione della comunità, il museo può avvalorare autenticamente questa relazione: attivare processi e non progetti, applicare il principio della concertazione e del coinvolgimento in azioni di carattere partecipativo, volte a costruire e condividere linee guida etiche e protocolli per l’attuazione migliorativa delle pratiche museali. Si tratta di adottare un decision-making process in grado di modificare, anche profondamente, l’istituzione e il suo contesto di riferimento. Questo nuovo tipo di “museo disponibile”, è tale solo se disposto ad accogliere le istanze della collettività.

Raccontaci l’esperienza di Castelbuono e di come un piccolo museo di provincia è riuscito a trasformare il proprio rapporto con il territorio e con lo scenario internazionale.
Da diversi anni, il Museo Civico di Castelbuono (un museo “quasi” tutto al femminile, dal CdA, al team di progettazione composto da professioniste di grande valore scientifico e umano) ha adottato un modello strategico integrato, che unisce tutela e valorizzazione del patrimonio locale materiale e immateriale attraverso formati partecipativi e rispettosi dei diversi pubblici che “abitano” il territorio e frequentano il museo. Ci interroghiamo su come raggiungere quei segmenti sociali che per ragioni diverse sono esclusi dalla partecipazione culturale, con l’obiettivo ambizioso, ma anche una costante nell’orientamento culturale dell’Istituzione, di divenire un interlocutore credibile e disponibile ad accogliere nuovi pubblici e sperimentare nuovi linguaggi e formati.
Ciascun progetto, esposizione, iniziativa promossa dal Museo prevede forme di partecipazione collettiva, rivolti anche ai fruitori temporanei. Si tratta di un museo di comunità, perché ha stretto un patto di collaborazione con la cittadinanza, sperimentando gli obiettivi espressi del Manifesto dei musei del territorio e dei piccoli borghi (2020), una dichiarazione elaborata a partire da prospettive interdisciplinari, quali arte, economia della cultura, pedagogia, antropologia. I piccoli borghi italiani incarnano infatti ciò che molti paesaggisti e architetti individuano oggi come i luoghi-simbolo di un futuro sostenibile, dove è possibile praticare la condizione di un bene comune vissuto come “un fascio di relazioni a doppio senso, che va dai soggetti alle cose e viceversa” – secondo la definizione data dal filosofo del diritto Francesco Viola. Per rendere efficace nel tempo questo sistema, già dal 2019 abbiamo attivato un dipartimento dedicato ai progetti partecipativi, che collabora con le sezioni di curatela, di grafica e comunicazione e educazione per sollecitare la partecipazione della comunità. Nel 2020, in piena pandemia, abbiamo avviato il nostro progetto ambientale “Orto dell’arte”, creato con un’associazione civica e con la collaborazione di una cooperativa di persone con diverse fragilità. Dopo alcuni anni di copiosi raccolti stagionali, oggi l’orto è diventato un giardino di erbe mediterranee ed è parte del percorso museale.

Il paradigma culturale sta cambiando. Stiamo passando dal paradigma dell’economia a quello dell’ecologia (V. Hosle docet). Come vengono ripensati i modi della produzione culturale in termini ecologici?
La transizione ecologica è un processo esteso ormai a tutti i campi sociali e del sapere, dall’economia alla cultura, dalla moda alla comunicazione. Si tratta di un cambiamento che ci impone una riflessione sulle questioni climatiche, sul consumo delle risorse naturali, ma anche sul modo in cui i musei possono contribuire a un futuro sostenibile, guidando l’innovazione. Se è vero, come ci insegna il filosofo Gilles Clemént, che per prenderci cura del nostro pianeta dobbiamo operare come giardinieri, i musei possono favorire processi di cura, percorsi di consapevolezza e responsabilità civica, anche attraverso una concezione trasversale del patrimonio.
Tra le attività che con il Museo Civico stiamo realizzando negli ultimi anni, ad esempio, c’è il format “Le Passeggiate dell’invisibile” alla scoperta dei percorsi naturalistici nel parco delle Madonie, accompagnati da mimi, musicisti, attori, esperti botanici e guide locali: per sensibilizzare alle questioni ambientali, attraverso un’offerta alternativa alla tradizionale visita dentro il museo. Come anche il Micro Festival di letteratura per famiglie “Asino chi legge”, con la partecipazione delle asinelle-spazzine che il Comune di Castelbuono impiega per la raccolta differenziata.

Come cambia il ruolo del pubblico in questo scenario?
Anche in ambito internazionale si è diffusa una cultura della partecipazione al patrimonio che vede le persone protagoniste di una dinamica fondata proprio su un rapporto orizzontale, democratico, dove il visitatore non è più semplicemente il destinatario-oggetto di una erogazione culturale calata dall’alto, ma diventa protagonista di una narrazione culturale condivisa. Un esempio è il Danish Welfare Museum di Svendborg, in Danimarca, dove i visitatori possono esplorare la storia delle istituzioni per poveri, orfani e detenuti, e l’evoluzione del welfare nel paese, attraverso il coinvolgimento diretto di persone della comunità locale, chiamate a lavorare come guide del museo. Il coinvolgimento della comunità è quindi una scelta che i musei possono intraprendere, con la consapevolezza che sono percorsi i cui gli obiettivi si costruiscono in modo condiviso e partecipato.
I ragazzi considerano ancora i musei come luoghi inaccessibili e inarrivabili…
Se la percezione del museo prima, e l’esperienza museale dopo, generano disagio, disinteresse, distanza, sarà essenziale ricostruire la narrazione museale secondo criteri accreditati. Ma non basta. Per coinvolgere meglio i più giovani dobbiamo cambiare forma e linguaggio. Ad esempio, tra le attività che riguardano la digitalizzazione del patrimonio culturale, con il Museo Civico di Castelbuono nel 2025 siamo tra le istituzioni italiane che partecipano al progetto “Dicolab. Cultura e digitale” della Scuola Nazionale del patrimonio e dei beni culturali, per la realizzazione di audioguide museali con contenuti co-progettati insieme a studenti e studentesse del liceo scientifico locale, nell’ambito del progetto TAP Tutoring. Un progetto che “affida” la narrazione del patrimonio alla creatività degli studenti, attori e protagonisti della storia e dell’eredità culturale locale.
Qual è, oggi la sfida maggiore per i musei e le istituzioni culturali?
Trasmettere il patrimonio al futuro senza svilirne il senso, essere disponibili ad accogliere il cambiamento in atto in un’epoca di caos climatico, sociale e politico. Ma anche riconoscere che il comparto dell’industria culturale non può essere preda di politiche “estrattive”, da cui trarre profitto. Il patrimonio culturale rappresenta la risorsa che i governi hanno per migliorare il welfare, per sostenere ricerca e innovazione, responsabilità e quindi impegno proattivo nella preservazione sostenibile del nostro patrimonio. Infine, attivando la filiera della produzione culturale, di generare benessere, anche turistico e quindi economico.

Recentemente hai preso parte a due importanti tavoli nazionali su questioni centrali tra i beni culturali e i cittadini, anche attraverso nuove tecnologie come l’IA, di cosa si tratta?
A settembre scorso il think tank del RavelloLab ha riunito oltre 100 esperti da tutta Italia a riflettere su prospettive e opportunità tra intelligenza artificiale e beni culturali, condensati nelle ‘raccomandazioni’ al Governo e agli stakeholder pubblici e privati per le politiche culturali del nostro paese. Un tema che è al centro del dibattito sull’applicazione dell’innovazione digitale a servizio della fruizione e dell’accessibilità del patrimonio. Il n. 58 della rivista scientifica “Territori della cultura”, pubblicata dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, e consultabile on line, ne raccoglie i principali risultati.
Più recentemente ho partecipato al Next Gen Heritage, quattro giorni di lavori, tenuti all’Università Cà Foscari di Venezia (29 gennaio-1 febbraio 2025) nell’ambito del grande progetto PNRR, finanziato dalla Fondazione CHANGES-Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society. In particolare ho contribuito al tavolo dedicato al ‘Citizen Science’, ovvero alle questioni che riguardano il nostro Codice dei Beni Culturali e i principi espressi nella Convenzione di Faro, collegando l’attuazione della progettazione “dal basso” con le attuali disposizioni statali. Gli esiti di questi tavoli riflettono lo “stato dell’arte” della partecipazione civica nell’ambito dei beni culturali, ma attraverso i numerosi contributi interdisciplinari, forniscono un richiamo per aggiornare valorizzazione, tutela (culturale) e promozione (turistica, sostenibile) dei beni e del patrimonio culturale.

Qual è l’obiettivo?
Per rispondere alle nuove istanze contemporanee, l’obiettivo comune è di accompagnare la natura trasformativa dei beni e del patrimonio culturale, accogliere la partecipazione, la co-progettazione come strumenti indispensabili per costruire nuovi modelli di governance aperta e condivisa sui territori: è il patrimonio a dover essere reso “disponibile” per la fruizione della collettività e non il contrario. I musei sono dispositivi di relazione con le comunità, mezzi straordinari per attraversare il cambiamento che stiamo vivendo.
In copertina: I. Waterhouse, Echoes_I.A., videocollage, collezione Museo Civico di Castelbuono.



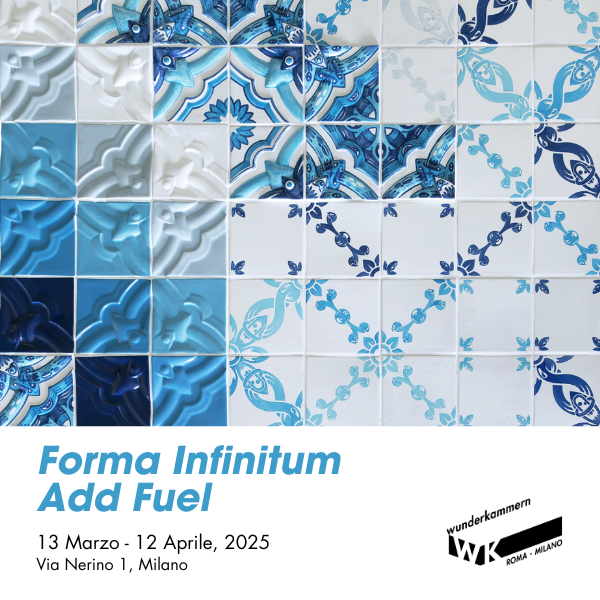

Bella intervista
Il articolo molto interessante, ma con parole semplici non da una idea concreta. Per cui io consiglia di vedere il sito
– deutsches museum münchen-
Che tramite le esposizione di modelli dare il visitatori la possibilità di capire certe cose, basta premere un pulsante. Ma anche la collaborazione con le scuole e molto importante, Perché da piccolo traverso le visite di musei si prendere confidenza con il sapere. Il lavoro che stato fatto a Castelbuono con il museo e molto piacevole e intressante. Si po per esempio fare un caccia al tesoro. Basta dare un foglio ogni visitatore i n cui sono indicati oggetti che si devono trovare e indicare in quali loci si trovano.
Contenuti di notevole importanza per stimolare ulteriormente quel necessario cambiamento che noi operatori del settore cerchiamo di mettere in pratica quotidianamente nel nostro lavoro. Necessari spunti di riflessione.