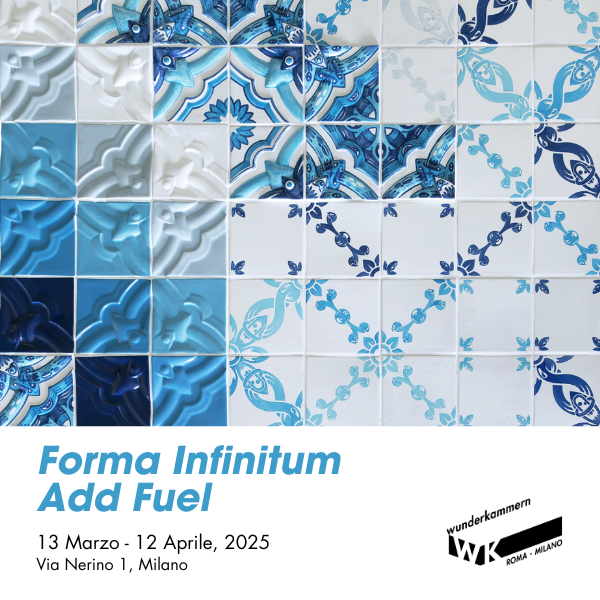Non staremo a disquisire di quanto e quale Gattopardo da schermo sia migliore dell’altro. La questione nasce più che altro dall’accezione di una contemporaneità. Perché ciò che definiamo contemporaneo, non è solo facilmente collocabile sulla linea del tempo del presente. Riesce infatti ad espandersi in virtù di quella natura che la rende attuale in ogni epoca. E quello che non cambia mai – in questa vita, in quelle passate e in quelle future – sono le persone, le anime, le emozioni.
Al di là della Sicilia, delle ambientazioni, del profumo dei fiori degli arabeggianti giardini e dei colori – egregiamente manifestati in entrambe le produzioni – pare ci sia molto altro a cui prestare attenzione. Gli straordinari costumi, coerenti o meno rispetto ai poco effervescenti outfit viscontiani, non possono e non devono distogliere l’attenzione da quella che era comunque una delle principali aspirazioni di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Ovvero dare vita ad un romanzo che di prassi viene definito storico e che eppure ha molto di psicologico. Dopo la sua pubblicazione, nel 1958, tanti sono stati gli studi e i tentativi di incasellarlo sotto questa o quella categoria. Si è parlato anche di romanzo antistorico, poi decadente. Resta il fatto che la vera definizione di quest’opera, che in tutta la sua complessità non merita delimitazione alcuna, è immortale.
Siamo tutti coscienti del fatto che l’immortalità passi dai ricordi, dagli sguardi, dalle parole. Dai sentimenti che non svaniscono. Così il Gattopardo – nella persona di Fabrizio Corbèra, Principe di Salina – e tutta la sua famiglia, sono sì coloro che vedono la storia cambiare, ma anche quelli che cambiano la loro storia. Il loro vissuto non è una linea piatta in balìa degli eventi, quanto più una cavalcata in sella ai cambiamenti del Risorgimento, che porta con sé sensazioni contrastanti ed evoluzione dei protagonisti.
E la più inevitabile delle distinzioni da fare tra il film di Luchino Visconti e la serie Netflix di Tom Shankland è che senza dubbio in quello che da ora in avanti chiameremo “il nuovo Gattopardo”, i personaggi hanno una sfera emotiva estremamente più sfaccettata. Lo stesso Tancredi risulta più maturo, abbandonato sì ai suoi mutevoli e talvolta superficiali istinti – dopotutto, è un giovane -, ma coerente alle sue ideologie e desideroso di portarle avanti: le difende con cognizione di causa, e non perché la trama ce lo stia suggerendo.

Impossibile non esortare, poi, ad un confronto sulla compagine femminile della storia. Visconti ci presenta delle inette di contorno, pronte a pregare anche nei momenti di più incredibile marasma. Maria Stella di Salina urla e si dispera per un nonnulla; Persino di Angelica, cosciente della sua bellezza ma in modo inconsapevolmente sciocco, non si riesce ad intuire il potenziale a lungo termine. Concetta poi – è il padre stesso a dirlo – è placida e sottomessa e non va bene per l’ambizioso nipote. In quello che è il triangolo amoroso della vicenda, pare quasi che Concetta abbia travisato i comportamenti di Tancredi. Non c’è spazio per le sue folli fantasie.
Ma Kim Rossi Stuart è un Gattopardo molto più umano. Nobile di sangue e d’animo. Di sua figlia rispetta il carattere e la personalità. Cosciente di provocarle un dolore, non minimizza i sentimenti di lei e se ne trascina la colpa. Austero per necessità, non sempre per volontà. Pur tradendo la moglie ne invoca talvolta la lungimiranza, riconoscendole la lealtà che spetta alla compagna di una vita.
L’estrema contemporaneità del nuovo Gattopardo sta nei sentimenti scaturiti dall’epoca storica in ascesa. Il Risorgimento porta con sé una rivoluzione che è umana, oltre che politica. La storia diviene la metafora di un senso di inadeguatezza crescente, lo specchio di uno spaesamento riscontrabile anche nella società di oggi, dove facciamo a volte fatica a disporci. E questo sentimento, che può facilmente passare da un Nobile siciliano vissuto nel 1800 ai giorni nostri è eterno, e per questo contemporaneo.

C’è una signorilità migliore, nella recente serie di Netflix. Una nobiltà che è fatta anche e soprattutto di rispetto del prossimo, del peso delle parole e delle proprie idee. Del comportarsi sempre secondo coscienza anche quando attorno succede tutt’altro. Se nel lungometraggio di Visconti il personaggio di Sedara ci appare come un losco ma ben più rozzo sindaco di paese, più costruita è la sua figura nella serie: un vero e proprio anti-eroe, le sue sono macchinazioni astute di un uomo che sguazza nel cambiamento con la sua ambiguità. Non si tratta solo della fine di un’epoca politica: è il doversi arrendere ad un mondo che non è all’altezza di quello per cui si è lavorato tanto.
E se la languidità di Angelica si mostra come il frutto di input errati, poiché convintamente solidale a Concetta, di tutta la vicenda, ne esce vincitrice proprio quest’ultima: non solo come erede del padre, ma come punto di riferimento di tutta una generazione che non è disposta a farsi cambiare dal mondo circostante.
L’umanizzazione dei protagonisti del nuovo Gattopardo è il motivo per il quale possiamo sentirli più vicini. Il passo successivo è quello dell’immedesimazione.
Non è che il nuovo Gattopardo sia migliore. È solo più vero.