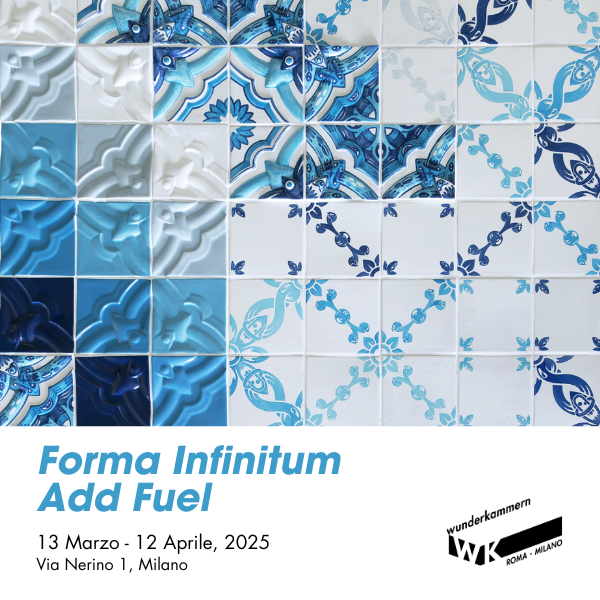Un viaggio cominciato otto anni fa, sette temi da approfondire, un gruppo di esperti che hanno creduto nel potenziale di un luogo e nella necessità di investire nella ricerca e nel territorio: sono questi alcuni degli elementi che hanno permesso a una equipe dell’Università del Salento di lavorare sul sito “Li Schiavoni” (Nardò, LE) e di portarlo in mostra, fino a maggio, al Museo della Preistoria di Nardò, in provincia di Lecce.
L’esposizione temporanea è dedicata agli scavi svolti a partire dal 2016 dall’Università del Salento, sotto la direzione scientifica della professoressa Giovanna Cera, che hanno permesso di indagare ed esporre i resti di un abitato messapico fortificato. Nel percorso, sono visibili le varie fasi dell’insediamento, frequentato con modalità differenti per circa 3000 anni. In più, è possibile ammirare le strutture emerse nel corso delle ricerche, oggi riprodotte con ricostruzione 3D, che diventano l’occasione per ricostruire antiche scene di vita quotidiana. Tra gli spazi portati alla luce: una cucina, una fornace, un magazzino per la ceramica, un muro di cinta e la sepoltura di una fanciulla con un ricco corredo (gli oggetti sono esposti all’interno della mostra).

«Da un sopralluogo effettuato nell’estate del 2012 con il dottor Lino Rollo, appassionato di archeologia e proprietario di un terreno in località Li Schiavoni, è nato il mio interesse per quel luogo, che visitavo in quell’occasione per la prima volta. Un luogo affascinante, ricco di segni del passato e dalla formidabile posizione in vista della costa» scrive Giovanna Cera, direttrice scientifica delle attività di ricerca presso il sito Li Schiavoni. «A distanza di 8 anni dall’avvio delle ricerche ho sentito l’esigenza di narrare, attraverso questa mostra, l’interessante vicenda storica di questo piccolo insediamento messapico affacciato sulla costa ionica del Salento. La sua storia non è quella di un centro emergente, la sua fisionomia non è quella di una città estesa e dotata di evidenze monumentali, bensì quella di un agglomerato di piccole dimensioni, con probabile funzione “satellite” nel sistema insediativo del territorio e con un ruolo di avamposto a controllo della costa».
Grazie all’utilizzo di tecnologie 3D, è stato possibile ricostruire edifici, paesaggi e manufatti, «offrendo una visione tridimensionale e immersiva che facilita una comprensione più intuitiva e immediata del contesto antico oggetto della mostra, rendendo la storia accessibile a persone di tutte le età e con diverse capacità cognitive e sensoriali». Lo scopo della ricerca è agevolare la fruizione del patrimonio archeologico e aprirne la comprensione anche a un pubblico di non esperti, «attraverso l’impiego di contenuti video elaborati a partire da ricostruzioni virtuali, che contestualizzano gli oggetti in mostra in modo semplice e immediato» spiegano Carola Gatto e Laura Corchia di AVR Lab, Università del Salento.

Per agevolare la visione della mostra, infatti, sono stati realizzati dei video in cui, attraverso le ricostruzioni 3D descritte nei pannelli, si può entrare virtualmente negli ambienti del tempo, guardarne le proporzioni e immaginarne le funzioni. Allo stesso scopo, nella vetrina con i reperti provenienti dalla sepoltura, c’è un QR code che permette di accedere a un audio in cui la fanciulla, chiamata Rania (il nome è stato preso da fonti epigrafiche messapiche trovate in altri luoghi) racconta la sua storia.
Sono stati sette i contesti approfonditi: il circuito murario, l’abitazione arcaica e la necropoli, il quartiere produttivo, il vano deposito, la fornace e la villa romana. «La stretta relazione con il territorio nel quale si svolgono le ricerche è una costante all’interno della mostra ed emerge dalla lettura e interpretazione delle tracce archeologiche individuate a Li Schiavoni, proposte nei pannelli didattici, dove si sottolinea il ruolo strategico del sito in rapporto con la viabilità e le rotte marittime che interessavano la vicina costa ionica del Salento» spiega Grazia Maria Signore, Direttrice del MUSA dell’Università del Salento «ma anche dai colori che lo caratterizzano (il rosso del terreno, i toni del verde della macchia mediterranea, il bianco dei blocchi delle fortificazioni e il blu intenso del cielo e del mare) ben rappresentati nel video visualizzabile sul monitor LCD presente nella sala».

Ma le sorprese non finiscono qui. Sulla fornace, aleggia un’aura di mistero: al suo interno, infatti, sono state trovate moltissime conchiglie, tutte della stessa specie. La ragione è ancora ignota, ma le ipotesi sono varie. La più probabile è che siano state radunate lì perché si prevedeva di darvi fuoco e produrre, in quel modo, calce, ma nulla è stato ancora confermato. Si tratta di un caso unico, mai attestato fino a oggi in altra bibliografia, né in altro luogo. Non solo: all’interno del sito archeologico, sono stati trovati i resti di un vaso di età romana, con un’iscrizione che farebbe riferimento alla produzione di un liberto che lavorava nel Nord Italia. Di questo esemplare sono stati trovati confronti anche in altri luoghi, tanto da rafforzare l’idea che il Salento rientrasse nei percorsi commerciali che, tra I a.C. e I d.C. mettevano in collegamento le due aree della penisola. Alle altre domande, in parte, rispondono i pannelli esposti nel museo; in parte, per adesso, l’immaginazione. In futuro, probabilmente a farlo sarà la ricerca.