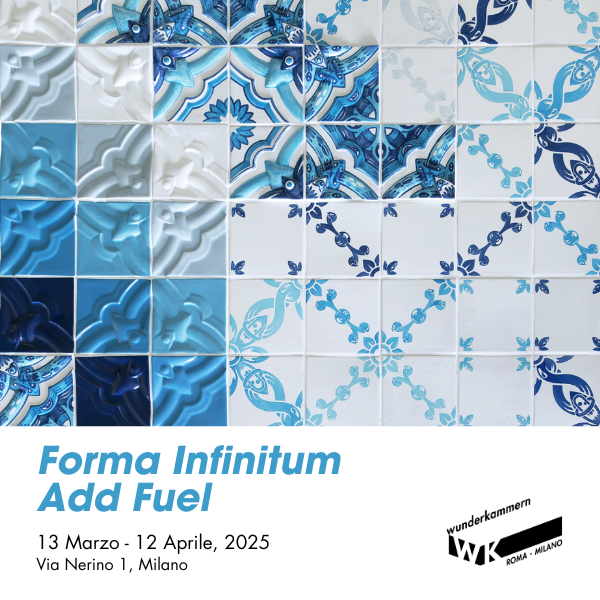“Ho deciso di parlare di femminismo perché è una cosa che mi tocca da vicino”.
Chimamanda Ngozi Adichie non si definisce femminista sin da subito, lascia che le sue idee precedano la categorizzazione. Classe 1977, nasce in un piccolo paese a sud della Nigeria e proprio a partire dalle sue radici racconta al mondo cosa significa essere donna, o come afferma la stessa autrice “Femminista Felice Africana”.

In occasione del TEDx Euston Conference del 2012, la scrittrice pronuncia un discorso che ancora oggi, a distanza di anni, riassume l’essenza del femminismo. Dovremmo essere tutti femministi parla di esperienze, lontane o vicine, che siano prova concreta della realtà che circonda le donne ogni giorno, al di là dei progressi verbalmente declamati. Chimamanda Ngozi Adichie matura l’identità femminista relazionandosi con diversi contesti socio-culturali, dalla Nigeria dove nasce, all’America dove studia e si stabilisce negli anni successivi; i limiti che sottolinea nelle pratiche quotidiane sono gli stessi limiti che evidenzia nella definizione di “femminismo”.

Gli stereotipi legati a questo termine comprimono l’ideologia alla base di una serie di immaginari collettivi: “odi gli uomini, odi i reggiseni, odi la cultura africana, pensi che le donne dovrebbero essere ai posti di comando, non ti trucchi, non ti depili, sei perennemente arrabbiata, non hai il senso dell’umorismo, non usi il deodorante”. Alla sua prima lezione di scrittura all’università, Chiamamanda prova in prima persona un momento di preoccupazione e di irrazionale insicurezza: l’estetica femminile che tanto ama le permetterà di dimostrare la sua preparazione? La rinuncia ad abiti piú succinti le permetteranno di essere presa piú sul serio? Verrà giudicata per i suoi gusti o per la sua cultura?
“Ho deciso di non scusarmi piú per la mia femminilità”
I tacchi alti, i lipgloss, gli abiti che gli uomini bramano criticare, tutto ció che rende Chiamamanda e ogni donna ció che è, dovrebbe essere avulso dallo sguardo maschile e solamente oggetto di soddisfazione e stima da noi stesse per noi stesse.
Non è stato semplice per l’autrice allontanarsi da pensieri interiorizzati per anni e da pratiche considerate normali e giuste, ma nella “banalità” delle esperienze quotidiane ha riconosciuto le radici di una profonda sottostima del problema di genere.
Le differenze genetiche che caratterizzano i due sessi sono stati nell’antichità termine di paragone e di scelta, favorendo la forza fisica dell’uomo, qualità imprescindibile per la sopravvivenza. Oggi le doti non dipendono dagli ormoni e le probabilità di successo dovrebbero essere legate a qualità creative, caratteriali e intellettuali; è innegabile che alcune realtà stiano investendo sulla parità di genere e sull’eliminazione di pensieri retrogradi, ma è anche vero che purtroppo non c’è stata un’evoluzione ideologica proporzionale rispetto a quella della specie.
“Il problema del genere è che prescrive come dovremmo essere invece di riconoscere come siamo”
Le aspettative di entrambi i generi hanno forgiato un’educazione pericolosamente orientata agli stereotipi attuali; la necessità di mettere in discussione determinati diktat porta a credere nella speranza di costruire un mondo migliore, più giusto e felice. Un decennio prima dell’uscita del film Barbie, Chimamanda ravvisa già le difficoltà che anche America Herrera cita nel celebre monologo che ha trovato in tutte le donne approvazione e triste coinvolgimento.
“Diciamo alle femmine: devi essere ambiziosa, ma non troppo. Devi puntare ad avere successo, ma non troppo, altrimenti minaccerai l’uomo. Se nella coppia guadagni di piú, fai finta che non sia cosí, soprattutto in pubblico, altrimenti lo renderai meno virile.”
Quando il suo amico Okoloma la definì per la prima volta femminista, la scrittrice cerca quella parola sul dizionario, ignara della portata di quel termine e legge: “Una persona che crede nell’eguaglianza sociale, politica ed economica dei sessi”. Ad oggi non esiste un’unica spiegazione per questa parola, ma Chimamanda offre una sua personale interpretazione: “un uomo o una donna che dice sí, esiste un problema con il genere cosí com’è concepito oggi e dobbiamo risolverlo, dobbiamo fare meglio. Tutti noi, donne e uomini, dobbiamo fare meglio”.