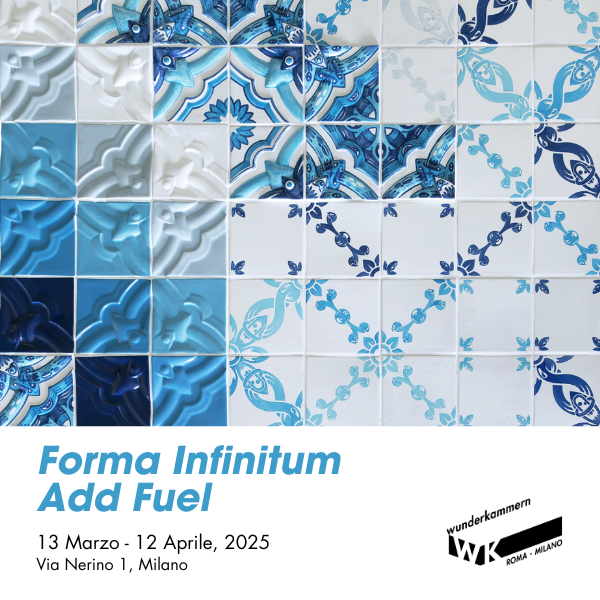MESSAGGERE è il titolo della nuova mostra inaugurata al Museo Novecento di Firenze lo scorso 8 marzo in occasione della festa della donna, e che sarà visitabile fino all’8 giugno. Le sale al piano terra accolgono il lavoro di una nuova generazione di artiste, Chiara Baima Poma, Fatima Bianchi, Lucia Cantò, e Parul B. Thacker; diverse per provenienza, formazione e modalità espressive, sono tutte accomunate da una ricerca che attinge ai sentimenti più profondi del genere umano. Le opere in mostra sono state tutte appositamente progettate e realizzate per gli spazi del museo, con l’obiettivo di indagare il rapporto tra arte e spiritualità, attraverso un inedito dialogo tra pratiche artistiche di diversa natura.
Per la realizzazione di questi lavori, le artiste si sono poste un’unica domanda che rivolgono anche agli stessi visitatori: può l’arte essere una forma di spiritualità, uno spazio personale e collettivo in cui sperimentare la fede, la ritualità, la trascendenza oltre la materialità, con l’idea di creare una nuova dimensione spazio-temporale? Le autrici diventano appunto le “messaggere” di questo pensiero, si fanno carico di questa riflessione personale da poi traslare e condividere sul piano collettivo, cercando di darne un significato non solo materiale e fisico, ma anche concettuale e filosofico.

La prima artista è Chiara Baima Poma (1990) rilegge e attualizza la tradizione della pittura sacra medievale e rinascimentale per aprire inediti varchi sul tempo presente; le sue opere sembrano vivere in una dimensione ‘altra’ e tradurre in immagini eventi e soggetti della cultura popolare o della tradizione religiosa.
Ricorrendo alla pittura e al collage, l’artista incastona figure dalla fisicità arcaica all’interno di paesaggi antinaturalistici, che si dispiegano astrattamente, in modo apparentemente piatto, sulla superficie bidimensionale dell’opera. Ricchi di particolari e animati da colori vivaci e da lavorazioni ‘antiche’, come inserti in foglia d’oro o in altri materiali,i suoi lavori richiamano alla memoria la minuzia preziosa delle miniature.
Oltre all’interesse per la pittura occidentale, Baima Poma combina nella sua ricerca suggestioni provenienti dall’incontro con tradizioni e culture diverse, spingendoci a riflettere sulle potenzialità terapeutiche dell’arte e sulla sua capacità di raccontare percorsi spirituali apparentemente distanti dalla nostra caotica e frenetica quotidianità. Rivela come i grandi interrogativi attorno ai quali ruota la nostra esistenza ritornino in ogni cultura e in ogni tempo. In mostra, opere della produzione più recente si affiancano a lavori inediti, ispirati alla sua ultima esperienza in Senegal, dove Baima Poma ha vissuto in stretto contatto con la comunità religiosa Baye Fall, rimanendo colpita dalle scelte di vita collettiva, dalla potenza dei riti e dalla spiritualità che emana e avvolge anche la dimensione più estetica e quotidiana.

Lucia Cantò (1995) indaga il ‘sentimento delle cose’, interrogando le forme e i loro molteplici significati. È artefice di opere che invitano a una riflessione profonda sul dualismo tra contenuto e contenitore, tra idea e immagine, tra il ‘qui e ora’ e un altrove passato o futuro. La sua ispirazione si muove per improvvise illuminazioni che vengono inizialmente trasposte in forma di poesie o di appunti, per poi essere tradotte attraverso le potenzialità fisiche ed espressive dei materiali. Nascono così lavori scultorei che invitano a interrogarsi sulla sottilissima soglia che separa il quotidiano dagli aspetti più trascendentali e inspiegabili che governano l’esistenza umana.
Nelle opere in mostra è centrale l’immagine del vaso, che può raccogliere e contenere molti significati, oltre che trattenere ricordi ed energie apparentemente nascoste. In Atti certi per corpi fragili (2021) troviamo coppie di vasi industriali assemblati e ricoperti di argilla; in Madre (2023) è presente un unico vaso in terracotta di grandi dimensioni, dove si sovrappongono equilibratamente tre elementi distinti. Sulla superficie si leggono alcuni pensieri scritti dalla madre dell’artista, che rinviano al potere generativo e trasformativo della figura femminile.
In mostra sono presenti anche le opere inedite come Venere (2025) e Ti dico un segreto: continua a guardarmi (2025) due opere in alabastro che riprendono il rapporto tra forma e contenitore ispirandosi agli stampi da dolci: una ricerca che racconta di legami familiari che aprono a nuove immagini sessualmente caratterizzate.

Le opere di Parul Thacker (1973) si mostrano come strutture complesse, che affondano le proprie radici nella forte spiritualità della sua terra. Gli studi compiuti in ambito matematico e della fisica quantistica si combinano alla filosofia e alle religioni orientali. La pratica di Thacker si fonda su sapienti procedimenti artigianali dove fili, tessuti, metalli, minerali, legno e pietre di ogni tipo si trasformano, come all’interno di un processo alchemico, rivelando le loro proprietà fisiche e simboliche. Dietro ai disegni, ai pannelli e alle installazioni in tessuto si celano arcane simbologie e riferimenti numerologici, che evocano l’eterno dialogo tra lo spirito e la materia.
Esemplare in tal senso è l’installazione ‘fluttuante’ The Book of The Time-Travellers of The Worlds: The One by Whom All Live, Who Lives by None (2023-24). L’opera è suddivisa in due capitoli che scandiscono l’attraversamento degli ambienti del museo tramite la disposizione di veli impalpabili, grandi tele di organza di seta, leggere e ricamate a mano. Le composizioni sonore in sottofondo accompagnano l’opera e combinano esecuzioni strumentali, registrazioni, e suoni archiviati e campionati durante alcuni viaggi dell’artista.
In quest’opera si ripresenta uno dei temi cari della produzione di Thacker, quello dell’acqua, così come i rimandi alla terra, all’aria e al fuoco, che aprono a una riflessione sui cambiamenti climatici e sulla perdita del legame tra uomo e natura.
All’interno dei Portali esposti nella ex cappella del museo, Thacker porta avanti una riflessione personale sull’individuo e sul suo rapporto con il cosmo e gli elementi che lo compongono; le opere fungono da “portali di transizione” invitando chiunque le osservi ad immergersi e interrogarsi sul loro possibile significato. In esse si unisce la scultura con la tecnica del ricamo.